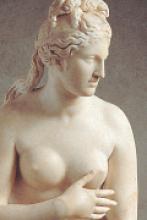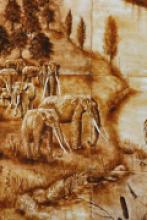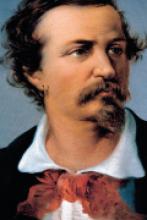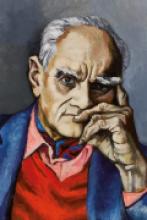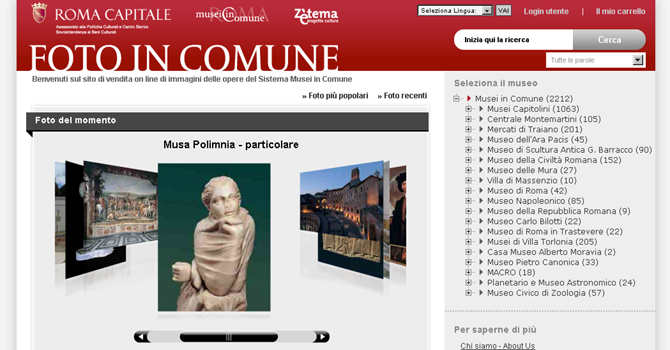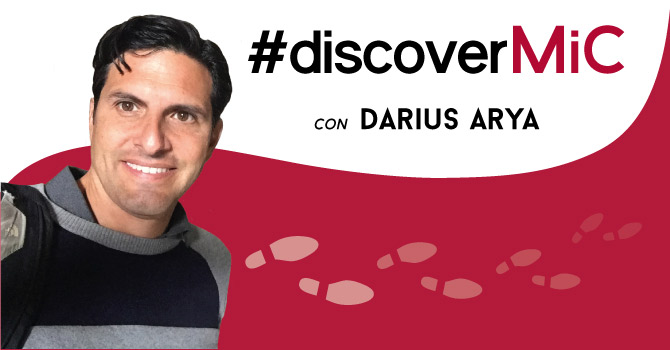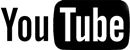Sotto i riflettori

Uno sguardo ravvicinato all’antico simbolo bronzeo di Roma nella sua splendida collocazione ai Musei Capitolini al fianco del Marco Aurelio.
Lo spostamento e la temporanea presentazione della Lupa Capitolina nella luminosissima sala, caratterizzata dalla presenza della statua equestre di Marco Aurelio, rappresenta l’avvio di un programma di messa in evidenza dei capolavori dei Musei Capitolini: si offre in tal modo l’opportunità di osservare le opere da vicino, apprezzarne le caratteristiche estetiche e di esecuzione artistica. Grazie ad un raffinato allestimento, i visitatori potranno a ammirare, come mai prima d’ora, questo magnifico bronzo, gioiello delle collezioni dei Musei Capitolini e autentico palinsesto della storia di Roma. Un allestimento creato per consentire al pubblico di apprezzare la perizia dell’artista e la sua straordinaria conoscenza dell’anatomia dell’animale, il suo estro creativo nel modellare la fiera solo apparentemente fissata nella sua vigile staticità, ma viva e vibrante nelle superfici incise.
Il mito rappresentato dalla Lupa, così come oggi la ammiriamo nella sua versione rinascimentale, si riferisce all’episodio narrato dagli antichi scrittori relativo al miracoloso salvataggio dei due gemelli, Romolo e Remo, figli di Marte e della vestale Rea Silvia, abbandonati alla corrente del Tevere, ritrovati presso il Velabro e amorosamente allattati da una lupa.
In età antica l’iconografia tradizionale mostra la Lupa che nutre i Gemelli con la testa rivolta verso Romolo e Remo, mentre la Lupa capitolina raffigura l’animale in un atteggiamento attento e vigile che non include necessariamente la loro presenza.
Questo bronzo straordinario, miracolosamente salvato dalle distruzioni seguite alla fine del mondo antico, è documentato per la prima volta nel IX secolo in Laterano, privo dei Gemelli e identificato quale simbolo della giustizia pontificia.
Nella realizzazione della testa l’artista ha saputo dare vita all’animale attraverso un modellato morbido, giocato tra il voluto arcaismo dei riccioli che incorniciano il volto e la plasticità del modellato del muso cui danno risalto le vene, le sopracciglia fortemente inarcate ma soprattutto l’occhio accuratamente modellato nelle sue cavità orbitali, predisposte per accogliere iride e pupilla realizzati in materiale diverso per dare maggiore incisività espressiva alla figura.
Il modellato della Lupa esprime, nel sapiente trattamento del disporsi del pelame sul collo e sul dorso dell’animale, la straordinaria capacità di uno scultore particolarmente dotato ed esperto nella lavorazione del modello in cera che consente di realizzare un’opera da considerare un autentico capolavoro della scultura antica.
I problemi ultimamente sollevati in relazione alla cronologia della Lupa, basati essenzialmente sull’interpretazione dei dati tecnici acquisiti nel recente restauro, hanno indotto alcuni studiosi a porre la realizzazione dell’opera in età medioevale. Va tuttavia rilevato che le “evidenze” di carattere tecnico portate a sostegno di tale ipotesi sono a tutt’oggi opinabili.
In un recente dibattito che si è svolto presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, numerosi ed autorevoli studiosi, sulla base delle stesse analisi suffragate da approfondite considerazioni di carattere storico-critico, hanno confermato la tradizionale datazione della Lupa al periodo compreso tra la fine del VI e i primi decenni del V secolo avanti Cristo.
La presentazione di quest’opera prestigiosa accanto agli imponenti resti del Tempio di Giove Capitolino, massima espressione architettonica dello stesso periodo, assume un particolare significato come espressione artistica di altissimo livello che getta una nuova luce sulla grandezza di Roma arcaica, ancora all’inizio della Repubblica.